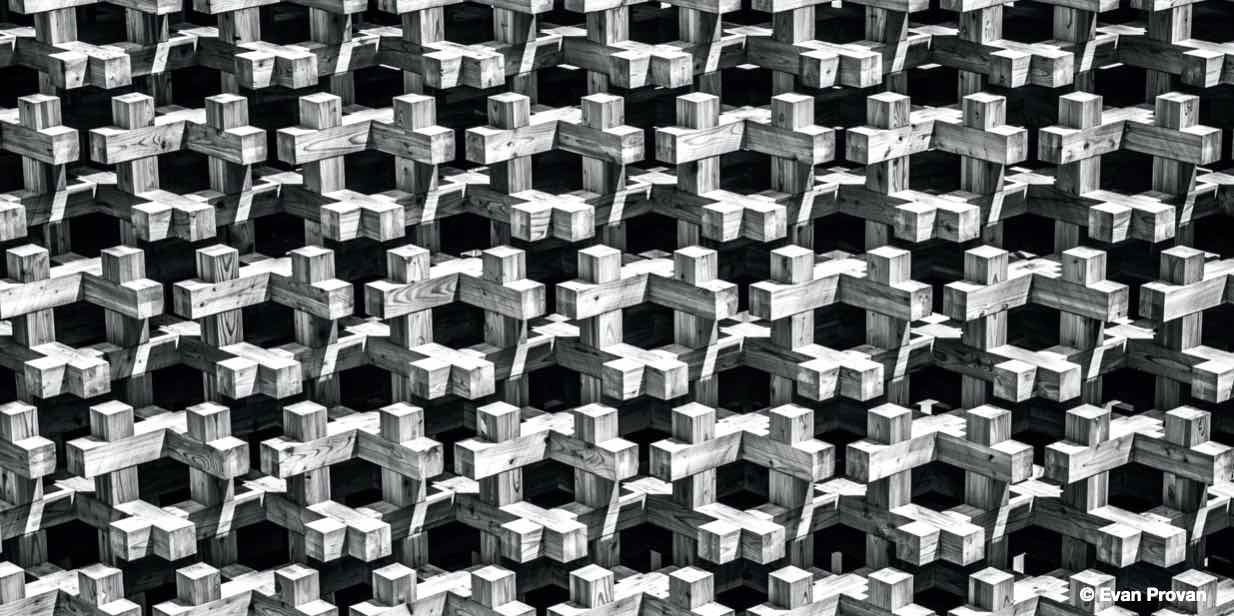Pubblicato il 13 dicembre 2018 su TennisAbstract – Traduzione di Edoardo Salvati
// Sembra esserci un consenso di fondo sulla rilevanza della componente mentale nel tennis. È meno chiaro però cosa significhi esattamente. Opinionisti e tifosi spesso si riferiscono a determinati giocatori come più forti o meno forti mentalmente, aspetto che aiuta a giustificare un eventuale divario tra talento e prestazioni.
Predominio, mano calda, continuità di risultato
Ci sono tre concetti a cui più si fa riferimento in una discussione sul “gioco mentale”: predominio nei momenti chiave, mano calda, continuità di risultato. Spesso ne ho criticato l’eccessivo utilizzo da parte dei commentatori televisivi. Ad esempio, servire un ace sulla palla break è considerato predominante, nel senso che quel giocatore ha imposto il suo gioco in un momento molto delicato.
Questo però non vuol dire che il giocatore possa essere descritto come predominante. Reagire bene alla pressione di specifiche situazioni non determina necessariamente che venga fatto più spesso della media.
Lo stesso vale per la “mano calda”: si tende a generalizzare in modo eccessivo da piccoli campioni di dati, quindi se un giocatore colpisce di fila tre rovesci lungolinea vincenti, si è portati a pensare che abbia la mano calda, anche se a volte può dipendere solo dalla fortuna.
È probabile che ci siano giocatori più predominanti, più con mano calda e più continui dei colleghi – o viceversa – anche oltre quanto è attribuibile al caso.
Contestualmente, nessun professionista è così tanto o poco predominante al punto che il suo gioco nelle fasi di maggiore importanza della partita spieghi in larga misura il suo successo o fallimento sul circuito.
Effetti ridotti
La maggior parte dei giocatori vince tanti tiebreak quanti ci si attende dal record di set che terminano con altro punteggio e trasforma palle break in numero pronosticatile dalle statistiche complessive alla risposta. Non accade nulla di magico nelle circostanze di maggiore pressione comunemente chiamate in causa, e non ci sono giocatori che diventano improvvisamente superman o materiale da discarica.
Se siete regolari fruitori del mio blog, è probabile che vi sia capitato di aver già letto sulla tematica, da me o da molti altri analisti di sport. Non voglio estremizzare dicendo che il predominio nei momenti chiave sia inesistente (o la mando calda o la continuità di risultato), mi preme evidenziare che questi effetti sono ridotti, così ridotti che difficilmente ce ne si accorge guardando le partite. E a volte così piccoli da mettere in difficoltà anche gli analisti nel distinguerli dalla casualità totale.
Eppure, rimaniamo con l’unanime, e invitante (!), convinzione che il tennis sia un gioco mentale. Nel tentativo di introdurre diversi tipi di modelli semplificati, scriverò sempre qualcosa del tipo: “sarebbe così se i giocatori fossero dei robot”. Per quanto alcuni di questi modelli siano decisamente precisi, credo che si sia tutti d’accordo sul fatto che i giocatori non sono dei robot, a eccezione forse di Milos Raonic.
Puramente mentale
C’è una versione estrema della convinzione che il tennis sia un gioco mentale che ho sentito attribuita a James Blake, quella per cui la differenza tra il numero 1 del mondo e il numero 100 è puramente mentale (immagino sia una eccessiva semplificazione del pensiero di Blake, ma sono opinioni diffuse a sufficienza da rendere l’idea di fondo degna di considerazione).
È un po’ dura da mandare giù. Chi infatti pensa che Radu Albot (l’attuale numero 99) abbia talento nella stessa misura di Rafael Nadal? Se ci allontaniamo un po’ dalle posizioni estreme, possiamo scorgerne l’attrazione.
Al momento, sia Bernard Tomic che Ernests Gulbis hanno una classifica tra il numero 80 e il 100. Si può affermare con sicurezza che entrambi non hanno talento quanto due tra i primi 10 come Kevin Anderson e Marin Cilic? Eppure spesso Tomic si mette in luce positiva in situazioni di pressione, mentre è Cilic quello a crollare.
Non è un problema di gestione della pressione
Il problema con Tomic, Gulbis e tanti degli innumerevoli giocatori che nella storia del tennis non hanno raggiunto grandi risultati non è la loro incapacità a gestire la pressione. Ricordiamo tutti partite, o set, o altre lunghe sequenze di gioco in cui un giocatore sembra disinteressato, poco motivato o senza energie per nessuna apparente ragione.
Anche tenendo conto dell’effetto o distorsione di selezione, penso che sia più probabile assistere a rendimenti inspiegabilmente mediocri da parte di giocatori che non hanno ottenuto risultati all’altezza delle aspettative (riuscite a immaginarvi Nadal non motivato? O Maria Sharapova?).
In senso molto ampio, li si può intendere come mano calda e continuità di risultato, ma non credo che siano gli esempi canonici a cui generalmente ci si riferisce. Operano invece su scala più larga, diciamo un intero set di mediocrità rispetto ad esempio a tre doppi falli in un solo game, e offrono una nuova modalità di pensiero sugli aspetti mentali del tennis.
Livello massimo sostenibile
Diamo a questa nuova variabile il nome di concentrazione. Ci sono innumerevoli potenziali distrazioni, interiori ed esterne a un giocatore, che ostacolano il raggiungimento della massima prestazione. Più un giocatore è in grado di ignorarle, metterle in un angolo o superarle, più è concentrato.
Ipotizziamo che ciascun giocatore abbia un personale livello massimo sostenibile di qualità di gioco e che, su una scala da 1 a 10, il massimo sia appunto 10 (sottolineo sostenibile per far capire che non si sta parlando delle volée smorzate dietro alla schiena da contorsionista di Agnieszka Radwanska, ma del miglior livello che un giocatore è effettivamente capace di mantenere. Il livello 10 di Nadal è diverso quindi dal 10 di Albot). Il valore di 1 alla base della scala si verifica raramente tra i professionisti, pensiamo a Guillermo Coria o Elena Dementieva che all’improvviso non riescono più a servire.
Maggiore la concentrazione, più spesso un giocatore si esprime al valore massimo di 10 e, per quanto non possa essere in grado di sostenerlo per tutta la partita, il giocatore più concentrato rimane più a lungo al livello 10.
Concentrazione, non continuità
Questa idea della concentrazione assomiglia molto alla vecchia definizione di continuità, e forse è quello che le persone hanno davvero in mente quando ne attribuiscono i meriti a un giocatore. Ma ci sono diverse ragioni per le quali credo sia necessario discostarsene.
La prima è pedanteria: continuità non è necessariamente un bene. Se si chiede a un giocatore di essere continuo e quel giocatore colpisce solo errori non forzati di dritto, ha seguito le istruzioni continuando a giocare male.
Più seriamente, la continuità è spesso associata al concetto di basso rischio, che però è una strategia, non un tratto positivo o negativo. Una giocatrice come Petra Kvitova non sarà mai continua perché il gioco aggressivo che la contraddistingue comporterà sempre molti errori, a volte decisamente negativi e occasionalmente in momenti sbagliati. Anche una strategia ottimale per una Kvitova al massimo della concentrazione sembrerà mancare di continuità.
Se non pensate altro che al tennis, la mia definizione di continuità vi apparirà molto limitata. Sono d’accordo, è un po’ provocatoria. Mi fosse possibile fare meglio di così nell’individuare in modo conciso di cosa parlano le persone in relazione alla continuità, lo farei.
Ripeto, parte del problema è l’eccessiva connotazione del termine. Anche se per continuità s’intende effettivamente concentrazione, ritengo sia importante trovare un’altra parola con meno peso.
Come negli scacchi
La concentrazione è davvero meglio delle altre caratteristiche di gioco mentale contro cui mi sono scagliato? Possiamo misurare in modo oggettivo il predominio nei momenti chiave, diventa molto più difficile analizzare i dati di una partita o di un’intera stagione e quantificare il livello di concentrazione raggiunto da un giocatore.
Tuttavia, ho il forte sospetto che tra i giocatori di vertice, la concentrazione vari di più, ad esempio, della mano calda in micro passaggi di gioco. Detta altrimenti: la differenza in concentrazione tra i migliori potrebbe essere la principale spiegazione di rendimenti differenti.
Ho incominciato a riflettere sull’importanza della concentrazione – ancora una volta, la capacità di sostenere il livello massimo di gioco o un livello appena inferiore per lunghi periodi – durante il Campionato del Mondo di Scacchi del mese scorso tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana (di cui ho scritto per l’Economist).
Appellativo di gioco mentale
Gli scacchi sono molto diversi dal tennis, è ovvio. Ma visto che non prevedono vigore, velocità o agilità di alcun tipo, hanno il diritto di arrogarsi l’appellativo di gioco mentale molto più di quanto spetti al tennis.
Pur dando spazio a momenti di splendore, le classiche partite di scacchi richiedono un livello di concentrazione così sostenuto che pochi riescono a comprendere. Basta un passaggio a vuoto contro un giocatore di élite che a quel punto è meglio abbandonare e riposarsi per la partita successiva.
Lo stereotipo più diffuso di grande maestro di scacchi è quello di una persona anziana che fa leva su esperienza e arguzia derivante da decenni di conoscenza per tenere a bada i giovani giocatori.
Eppure Carlsen e Caruana, i primi 2 del mondo, non hanno ancora compiuto trent’anni. Tra gli attuali primi 30, solo quattro giocatori sono nati prima del 1980, dodici negli anni ’90 e due dopo il 1998. La distribuzione dell’età dei più forti negli scacchi è incredibilmente simile a quella dei vertici del tennis.
Curve d’invecchiamento simili
La curva d’invecchiamento nel tennis si presta a una facile spiegazione. I giocatori possono iniziare a scalare la classifica al raggiungimento della maturità fisica verso la fine dell’adolescenza. Continuano a migliorare tra i venti e i trent’anni beneficiando di maggiore esperienza e di un fisico allenato per sopportare qualsiasi sollecitazione. Poi subentra il deterioramento fisico, i cui effetti iniziano a sentirsi verso i trent’anni, aumentando con il passare del tempo.
C’è naturalmente un fondo di verità in questo. Non importa quanto sia rilevante l’aspetto mentale, è difficile rimanere competitivi se si è perso in velocità o resistenza. E diventa ancora più dura con dolori cronici alla schiena o alle ginocchia.
Ma l’analogia con gli scacchi rimane valida: se il tennis fosse un gioco mentale, con la concentrazione a giustificare gran parte della variazione tra giocatori di vertice, la curva d’invecchiamento sarebbe quasi identica agli scacchi.
I miglioramenti introdotti dalla scienza moderna nelle tecniche di allenamento, di alimentazione e di recupero dagli infortuni hanno portato – grazie alla riduzione degli effetti di deterioramento fisico – a un appiattimento della curva d’invecchiamento del tennis verso la fine dei venti e l’inizio dei trent’anni.
In altre parole, la mitigazione della componente di rischio fisico determina una traiettoria della carriera dei giocatori d’élite nel tennis ancora più simile a quella degli scacchi.
Uno sguardo in avanti
Al momento, è solo un’ipotesi. Si può essere d’accordo che sia molto intrigante, ma resta non dimostrata, e probabilmente è estremamente complessa da dimostrare.
Se una concentrazione sostenuta è un fattore così rilevante nella prestazione dei vertici del tennis, come riusciamo anche solo a identificarla? Il metodo più diretto sarebbe quello di evitare del tutto il campo e studiare esperimenti di misurazione della concentrazione dei più forti. Dubito però si possa convincere i primi 100 della classifica a passare una divertente giornata di test in laboratorio.
C’è tuttavia del potenziale di lungo termine, perché è quello che le federazioni nazionali potrebbero fare con le loro giovani promesse. Anzi, potrebbe essere che alcune lo stiano già facendo. Ad esempio, alcune squadre professioniste americane di baseball e pallacanestro prevedono test cognitivi per valutare giocatori da mettere sotto contratto.
No cavie da laboratorio
Purtroppo, non possiamo fare dei migliori giocatori del mondo delle cavie. Se considerassimo invece i risultati delle partite, potremmo provare a calcolare la concentrazione con un approccio simile a quello che ho adottato prima in nome della quantificazione della continuità (oops!).
Il precedente algoritmo provava a misurare la prevedibilità dei risultati di un giocatore, vale a dire capire se l’undicesimo migliore del mondo perde dai primi 10 ma batte tutti gli altri o se il suo rendimento è meno pronosticabile. Non è quello a cui siamo interessati ora, perché per definizione la continuità non è necessariamente positiva.
Si può però seguire un percorso simile. Con in mano uno o più anni di risultati, si potrebbe stimare il livello massimo di un giocatore, magari con la media dei suoi cinque migliori risultati (il miglior risultato in assoluto potrebbe dipendere da un infortunio dell’avversario, una sospensione per pioggia nel momento sbagliato o un altro episodio inusuale). Avremmo così definito il livello 10 nella scala da 1 a 10 di quel giocatore.
A questo punto, confrontiamo gli altri risultati con il suo massimo. Se la maggior parte è vicina a quel livello – cioè il giocatore con continuità di gioco che perde dai primi 10 ma batte tutti gli altri – sembra allora essere concentrato, almeno da una partita all’altra. Se invece accumula molte sconfitte nette, non riesce a sostenere il livello di cui lo sappiamo capace.
Conclusioni
Non è un metodo totalmente soddisfacente, come spesso accade quando si opera con statistiche riguardanti un’intera partita. Forse, si potrebbe fare ancora meglio con dati specifici sui colpi o generati da sistemi come Hawk-Eye. Con un approccio come quello descritto – stabilire un massimo come termine di paragone – si potrebbero analizzare la velocità o l’efficacia al servizio, la frequenza delle risposte in gioco, la conversione delle opportunità a rete, e così via.
Sarebbe complicato, in parte perché la bravura dell’avversario e la velocità della superficie hanno sempre la possibilità di incidere su quei numeri, ma credo valga la pena approfondire. Se ho ragione, se cioè il tennis non è solo un gioco mentale, ma è profondamente influenzato da una concentrazione sostenuta, l’impatto di lungo termine è sullo sviluppo dei giocatori. Scuole e allenatori dedicano già molto tempo alle strategie, usando anche idee derivate dalla psicologia. Sarebbe un passo ulteriore in quella direzione.
La componente mentale nel tennis, e nello sport in generale, resta un caotico groviglio di aspetti sconosciuti. E, visto che la nuova generazione di giocatori d’élite è alla ricerca di piccoli miglioramenti tecnico-tattici da cui ricavare un vantaggio, forse la componente mentale è davvero la prossima frontiera, quella che permetterà alle nuove leve di ribaltare l’ordine precostituito. ◼︎